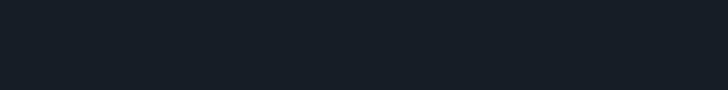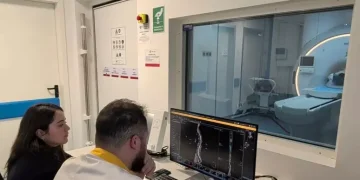Da molto tempo la performance art rappresenta uno strumento di provocazione, una forma d’arte che si è sviluppata attorno alla forza espressiva di un corpo nello spazio, stravolgendo le regole dell’ordinario per rivelare verità più profonde, sia di natura etica che politica.
La performance di Nicola Mette intitolata “Bentu Estu”, espressione in sardo che si riferisce al Maestrale vento potente e impetuoso.
Ambientata sullo sfondo dell’area archeologica Su Nuraxi a Barumini, patrimonio UNESCO portata alla luce dall’archeologo Giovanni Lilliu nel corso degli anni 40-50 del novecento, la performance di Mette è un lamento per i paesaggi fratturati dall’inarrestabile avanzata della cosiddetta industrializzazione “verde”.
Il titolo Bentu Estu evoca il mito di Eolo, il dio greco dei venti che fece dono all’umanità della forza dell’aria, ma nel contempo la utilizzò anche per punirla. Nell’Odissea di Omero, Eolo affidò a Ulisse un otre contenente dei venti, affinché lo conducessero a casa, ma a causa della loro avidità, gli uomini del suo equipaggio li liberarono, scatenando una tempesta che fece naufragare le loro speranze. L’opera di Mette per alcuni aspetti rievoca questo antico monito: il vento, un tempo forza della natura legato alla sopravvivenza, è diventato un ulteriore strumento di sfruttamento. Le alte turbine, sebbene presentate come simbolo di progresso, sono anche causa di rottura, in quanto spezzano la linea dell’orizzonte, violano territori sacri e ridisegnano la mappa della Sardegna, incuranti del suo patrimonio archeologico e culturale.
Un gruppo di volontari si posizioneranno a fianco all’area archeologica “Su Nuraxi”, nudi e indifesi. I loro corpi saranno dipinti di bianco, a simboleggiare gigantesche pale eoliche, con le braccia tese come lame. Tuttavia, la similitudine sarà stravolta da striature di colore rosso, a suggerire le ferite, le amputazioni e la violenza causate dai confini imposti. Il rosso evoca il nastro che delimita la terra, bloccandone l’accesso, e trasformando il territorio da bene pubblico a proprietà privata delle società.
I performer si trasformeranno sia in monumenti che in vittime, e i loro corpi rappresenteranno le strutture che deturpano il territorio che cercano di proteggere.
I Futuristi italiani, pionieri della performance art, un tempo esaltavano il rombo dei motori, la velocità dell’industria e la distruzione del passato in nome del nuovo. Il Manifesto Futurista di Marinetti (1909) dichiara guerra alla tradizione, celebrando la “bellezza della velocità” e la “vittoria dell’uomo sulla natura”. Un secolo più tardi, l’opera di Mette si pone in contrapposizione rispetto a tale acritica esaltazione del progresso. Laddove i Futuristi vedevano emancipazione nella macchina, Bentu Estu ne pone in evidenza i costi, non solo in termini di rispetto dell’ambiente, ma anche esistenziali. Il quesito di fondo della performance è: che cosa si perde quando il progresso si misura esclusivamente in megawatt, quando il paesaggio è considerato alla stregua di un contenitore vuoto anziché un archivio vivente? Lo spazio pubblico non esiste a priori: si crea attraverso l’azione, la presenza collettiva. La performance art, soprattutto quando si svolge nei luoghi oggetto di contestazione, non si limita a occupare dello spazio, bensì lo rende pubblico.
L’intervento di Mette a Su Nuraxi è un atto di riappropriazione, un modo per affermare che la terra non è solo una risorsa; essa è luogo di memoria, appartenenza e conflitto. Il fatto di presentarsi nudi, indifesi e con il corpo dipinto trasforma lo spazio archeologico, solitamente percepito come statico e distante, in un luogo di resistenza politica e poetica. In un luogo simbolo della civiltà nuragica, la presenza dei corpi nudi richiama l’urgenza di opporsi a nuove forme di colonizzazione paesaggistica, mascherate da progresso e sostenibilità. Le performance che avvengono in luoghi pubblici si collocano tra il teatro e la protesta, tra il simbolico e il letterale. Si generano attriti, costringendo gli spettatori a confrontarsi con ciò che l’abitudine ha reso invisibile. Inserendo il corpo, fragile e transitorio, all’interno delle rigide architetture del potere e della storia, Mette pone in evidenza l’assurdità del concetto di trattare il territorio come una tela bianca. Il corpo dei performer diventa esso stesso architettura, monumento effimero di ciò che rischia di essere cancellato.
La performance art non si limita a rappresentare la realtà: la inscena, creando esperienze di natura emotiva che permangono a lungo ben oltre la presenza dei corpi. Bentu Estu non costituisce una critica passiva, bensì incarna una forma di critica, è un severo monito del fatto che l’estrazione di energia non è mai neutrale, ma implica sempre la questione di chi sia a pagarne il prezzo. I corpi dipinti di bianco e striati di rosso, forieri di un possibile futuro e testimoni del presente, costituiscono un’immagine spettrale e potente.
In un’epoca in cui si celebra l’”energia verde” in modo spesso acritico, l’opera di Mette pone in discussione l’intera narrativa, sollevando la questione: a quale prezzo? E per chi? Le turbine eoliche, che girano incessantemente, potrebbero essere la promessa di un futuro più pulito, tuttavia Bentu Estu ci ricorda che il progresso non avviene mai senza un costo. La terra lo ricorda. Il corpo lo ricorda. E la performance art, sebbene in modo transitorio eppur indelebile, fa in modo che lo ricordiamo anche noi.
Con Bentu Estu, Nicola Mette non si limita a protestare: evoca. Richiama i venti presenti nella mitologia e nella storia, facendo vibrare la nostra coscienza collettiva. La performance è un momento magico, un monito, un invito a vedere il paesaggio non come risorsa da sfruttare, bensì come corpo vivente e patrimonio culturale.